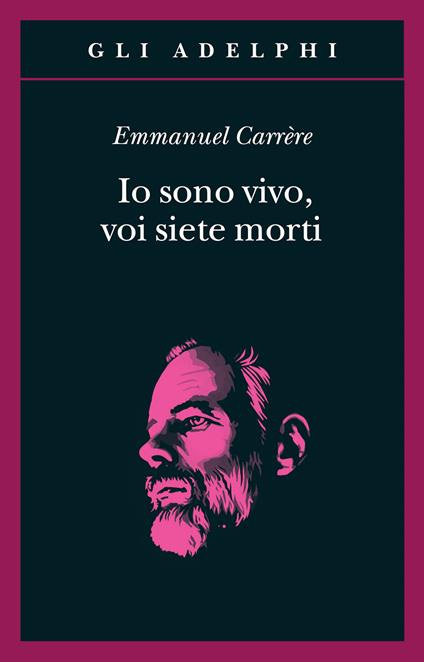#5 Un'avventurosa condivisione
Un critico letterario si chiede quale sia la posta in gioco quando leggiamo
Bentornati. Qui ci piace parlare di libri, ma anche dei modi possibili in cui di libri si può parlare.
Due settimane fa, per esempio, abbiamo parlato del Booktok insieme a Lara Marrama (se ve lo siete perso potete recuperare qui, ne vale la pena). Oggi invece si parla di forme di critica letteraria più classiche, sulla scorta di un grande critico come James Wood.
A seguire, come sempre, vi propongo un bel po' di articoli interessanti. E poi Emmanuel Carrère che incontra Philip Dick.
Incominciamo!
Un’avventurosa condivisione
Vi capita mai di chiedervi quale sia la posta in gioco di quello che state leggendo? Quale è la posta di quel romanzo, di quel racconto, di quel saggio? Secondo James Wood questa è la domanda che innesca sempre il lavoro del critico letterario. A seconda di quello che si intende per “posta in gioco” e degli strumenti utilizzati per individuarla derivano, però, forme di critica molto diverse.
James Wood è uno dei critici letterari più famosi del mondo. Per Minimum Fax è da poco uscito Come funziona la critica (traduzione italiana di Raffaella Vitangeli), una raccolta di suoi saggi brevi. Gli scrittori affrontati nel volume spaziano da classici assoluti come Cervantes e Cechov, a classici contemporanei come Cormac McCarthy e Paul Auster, a fenomeni recenti come Elena Ferrante.
Il titolo si rifà al più celebre tra i libri di Wood, ovvero Come funzionano i romanzi. Ma ovviamente questo nuovo libro non spiega realmente “come funziona la critica”, semmai mostra qualche ottimo esempio di uno dei modi in cui si può farla. Solo nell’introduzione (dove mi voglio soffermare) viene lanciato, senza alcuna pretesa di sistematicità, qualche spunto teorico.
È appunto nella introduzione che Wood parla della posta in gioco di un testo e spiega che a seconda di quello che si intende per “posta” si distinguono i due principali tipi di critica, quella accademica e quella giornalistico-letteraria. Il secondo tipo è quella che interessa principalmente a noi e anche a Wood. E ciò che caratterizza maggiormente questo tipo di critica è la continuità tra critico e scrittore.
Del resto, ciò che differenzia la critica letteraria da altri tipi di “discorsi sull’arte” è «il privilegio di realizzarla con lo stesso mezzo che si sta descrivendo», cioè la scrittura. Un critico, insomma, condivide buona parte della sua cassetta degli attrezzi con gli scrittori di cui si occupa. Ma a questo punto, allora, sugli scritti del critico si può sollevare la stessa domanda che si pone sui testi dello scrittore, qual è la posta in gioco?
Secondo Wood la posta è la condivisione di una esperienza: l’esperienza dell’incontro col testo. «Vuoi fare in modo che l’ascoltatore senta (o veda) la stessa cosa che senti (o vedi) tu – scrive – vorresti condividere quell’esperienza. La critica è esattamente questo». E qui Wood cita il filosofo Stanley Cavel: «La descrizione della propria esperienza artistica è essa stessa una forma d’arte; l’onere di descriverla è paragonabile all’onere di realizzarla». L’arte del critico (poiché stando a Cavel di arte si tratta) sarebbe quindi un’arte della condivisione e della descrizione.
O meglio, più che di descrizione si tratta di «ri-descrizione». Qualcosa che potrebbe essere definito “fare la parafrasi”. Termine spesso vituperato, eppure, anche una parafrasi è operazione che per essere fatta bene richiede notevole acume interpretativo. È qualcosa di simile a una ecfrasi (la descrizione verbale di una opera d’arte visiva), ma fatta, come dicevamo, con un linguaggio omogeneo a ciò che si sta descrivendo, quindi capace di andare più in profondità.
Wood, altrove nel libro, cita anche il critico d’arte John Berger che parlando di opere visive diceva che «disegnare è guardare, esaminare la struttura delle apparenze. Il disegno di un albero non mostra un albero, ma un albero che viene osservato». Allo stesso modo possiamo dire che la descrizione (o ri-descrizione) di un’opera letteraria non ne mostra i contenuti, mostra una forma di attenzione verso quell’opera. Attenzione che il lettore del critico può fare propria
E qui ritorniamo al concetto di condivisione. «Il massimo cui un critico può aspirare – continua Wood – attirando l’attenzione su alcuni elementi di quell’opera, ri-descivendo quell’opera, è riuscire a instillare nel suo pubblico un punto di vista simile sull’opera in esame». Piuttosto che una interpretazione (sempre parziale) quello che un critico può donare al lettore è un modo di guardare al testo.
Rassegna 🗞️
Sul cibo: Da Pinocchio a Masterchef
E se le neuroscienze fossero un re nudo?
È tornata la lotta di classe (o almeno ci si prova)
Fotografia che turba l’universo
Il fronte culturale della guerra in Ucraina
Quando Truman Capote organizzò la festa del secolo
Federigo Tozzi l’eterno snobbato
Diario di lettura 📖
Se ultimamente vie è capitato di guardare una immagine chiedendovi se fosse reale oppure creata dall'intelligenza artificiale, sappiate che stavate vivendo una esperienza dickiana.
Philip K. Dick è il capostipite e tutt'ora probabilmente il più grande esponente di quella che può essere definita fantascienza paranoica e che oggi è ormai parte integrante dell’immaginatio comune: scenari dove è impossibile distinguere cosa è vero e cosa è finto, cosa è realtà e cosa simulazione, chi è umano e chi androide.
Scritto nel 1993, Io sono vivo, voi siete morti (Adelphi, traduzione di Federica e Lorenza Di Lella) è il primo libro di non-fiction di Emmanuel Carrére. Una "biografia d'autore" con cui lo scrittore francese omaggia uno degli idoli letterari della sua giovinezza.
In questo libro (il cui titolo viene da una frase iconica del romanzo Ubik) Philip Dick appare come un moderno Don Chisciotte. Anche lui, come tanti suoi personaggi, eternamente sospeso tra realtà e sconfinamenti altrove. Una vita complicata segnata da frustrazioni letterarie, abusi di farmaci e droghe, relazioni turbolente con ben cinque mogli, ospedali psichiatrici, rivelazioni mistiche, speculazioni metafisiche e teologiche che lui stesso ribaltava con controcanti ironici.
La prosa flessibile di Carrére è particolarmente adatta ad accompagnare il lettore nella mente labirintica e contradditoria di Dick e intanto indagare gli strani percorsi con cui lo scrittore geniale seppe riversare nei suoi romanzi la sua visione del mondo e il suo inesauribile interrogarsi sulla realtà.
Una citazione per concludere 🖋️
L'arte dello scrivere è una attività assai futile se non comporta anzitutto l'arte di vedere il mondo come potenzialità narrativa
Vladimir Nabokov, Lezioni di letteratura
E siamo arrivati alla fine.
Se sei qui per la prima volta e vuoi recuperare le uscite precedenti le trovi tutte qui
Se vuoi supportarmi aiutami a far conoscere questa newsletter inoltrandola, condividendola, consigliandola. E ovviamente (se non l’hai già fatto) iscriviti.
Ci vediamo tra due settimane, buone letture!